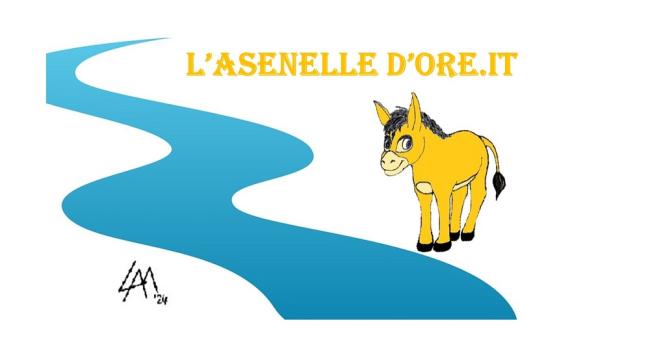In questa rubrica ospitiamo per la prima volta gli articoli di una collaboratrice che intende rimanere riservata e che pertanto si firma con lo pseudonimo di Perpetua.Come il personaggio manzoniano della governante di don Abbondio, ci propone articoli in cui analizza brani, personaggi ed aspetti derivanti dai Vangeli e riguardanti il Cristianesimo in generale, con il buon senso della storia, della scienza e delle altre dottrine in cui si articola la ragione umana, senza per questo entrare in contrasto con la teologia, ma anzi, se vogliamo, fornendo a quest’ultima nuovi spunti che gettano una luce nuova sui tanti argomenti analizzati.
Perpetua
IL «PADRE NOSTRO...»
Dopo quelli pubblicati su immicasalbordino.org e su apassoduomo.it, ho il piacere di iniziare, su questa testata, un miniciclo di articoli su tre aspetti importanti del Cristianesimo: il Padre Nostro, il peccato originale e la Resurrezione.N. d. A.
Il «Padre nostro...», la preghiera senza dubbio più celebre del Cristianesimo, perché la sola insegnata direttamente da Gesù, ci è stata tramandata da due Vangeli su quattro, quello di Matteo e quello di Luca, nonché, indirettamente, da un versetto di Marco.
Gli episodi che lo riportano si inquadrano in due contesti diversi derivanti dalle diverse impostazioni dei due Vangeli: quello di Luca si colloca in una impostazione storica che cerca di narrare la storia di Gesù con i criteri della storiografia greca, che si affida ai testimoni per garantire la verità di quanto raccontato e che inquadra un rapporto tra Gesù e i suoi discepoli di derivazione appunto greca, che ci racconta gli insegnamenti di un filosofo ai suoi allievi, quasi fossero Socrate con Platone e gli altri, cosicché il Maestro risponde ad una specifica loro domanda: istituzionale, quale quella appunto che chiede: - Signore, insegnaci a pregare.- .
Quello di Matteo, invece, rientra in una impostazione generale, per così dire “popolareggiante”, che registra, a cura dell’Evangelista che funge quasi da giornalista, la versione cioè della storia di Gesù e dei Suoi insegnamenti e discorsi più notevoli, quasi fosse un’antologia o uno zibaldone, così come circolava nella comunità ebraica di Gerusalemme, in esilio dopo il 70 d.C., che, di fronte all’espansione del Cristianesimo tra le genti di lingua e cultura greca, tende a considerare Gesù ancora soprattutto come un profeta ebraico, venuto quindi, innanzitutto, per il popolo eletto degli Ebrei, tanto da cominciare il Vangelo con una genealogia ebraica del Salvatore ad iniziare addirittura da Adamo e che pertanto vede Gesù in discussione con i capi religiosi del suo tempo che si sono allontanati da Dio, dalle sue norme e dai suoi comandamenti.
In particolare, il passo interessato di Matteo è quello determinato dai seguenti versetti (6, 7-15):
7Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. 8Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. 9Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome;
10venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
11Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
12e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
13e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
14Se voi, infatti, perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; 15ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
Il passo comincia con l’accusa diretta ai pagani di dedicare troppe parole alle preghiere verso i loro dei, ma francamente questa sembra più l’accusa proveniente da un ebreo osservante che direttamente dalla bocca di Gesù, perché Lui saprebbe benissimo che il genere “preghiera” risulta essere tra i più produttivi della poesia di ogni tempo, specialmente per noi cristiani che consideriamo la divinità una persona di famiglia, un Padre appunto a cui dire, anche in modo commovente e persuasivo, tutti i nostri sentimenti ed esigenze, così come avviene pure con i Santi.
Peraltro, è anche verissimo che: «il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno», ma a questo punto ci si potrebbe anche chiedere: «A che serve pregare se è così? E allora che cosa dovrebbero dire i musulmani che pregano cinque volte al giorno in una religione come la loro che prescrive un abbandono totale alla volontà di Dio?» Ma pregare serve soprattutto a noi e a ricordarci continuamente di avere sempre a disposizione. Qualcuno su cui contare, in ogni situazione, anche prendendosela un po’ con Lui, perché no? e senza perdere mai la speranza.
Passando oltre, la preghiera inizia con il verso: «Padre nostro che sei nei cieli». Che il Padre si trovi nei cieli sembra indirettamente confermato anche dall’unico versetto di Marco sull’argomento, nel cap. 11, versetto. 26, («il Padre vostro, che è nei cieli») che sancisce anche il parallelismo tra remissione dei nostri peccati e quella che noi dovremmo fare ai nostri debitori. Il catechismo ufficiale peraltro afferma invece che Dio si trova in cielo, in terra e in ogni luogo, ma è da considerare che allora non si teneva certo conto della Trinità e che il luogo della divinità era, per sua stessa natura, il cielo.
Il verso successivo della preghiera e alcuni di quelli seguenti sono poi collegati tra loro da un legame di carattere modale, nel senso che viene chiarito dai versi successivi come si fa a santificare il nome di Dio.
E dunque per far sì che «sia santificato il tuo nome», ossia rendere il nome di Dio più importante di ogni altra cosa, bisogna innanzitutto che venga realizzato sulla terra il Suo Regno (pertanto mi sembra che tradurre il verbo latino “adveniat”, di “adveniatRegnumtuum”, con il semplice venga, sia un po’ riduttivo, perché nel prefisso “ad” di “adveniat” è sottointeso il significato di “finem”, compimento, e che sia invece molto più adatto dunque “giunga (a compimento)”, “si compia”, “si realizzi”, al limite, appunto, “venga realizzato”),cioè che, come dice il verso successivo, «sia fatta la tua volontà», vale a dire mettere in pratica i suoi comandamenti, il che ci consentirebbe di vivere in un mondo di giustizia e di pace.
Per far questo, però, bisognerebbe che questa volontà sia messa in pratica «come in cielo così in terra», sempre e nel modo in cui Dio desidera, come avviene in cielo, il che non è sempre possibile, qui sulla terra, visti i difetti e il male che c’è negli uomini, per cui occorre appunto l’aiuto della Divinità.
Dopo questo blocco di versi tra loro collegati, la preghiera va avanti con un’altra espressione che riguarda il sostentamento materiale: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», e che sirichiama alla distribuzione giornaliera di quaglie e manna effettuata da Dio per nutrire gli Ebrei nel deserto dopo la traversata del Mar Rosso. Questa espressione si può intendere in un duplice modo: sia nel senso che bisogna sempre essere coscienti della propria precarietà e quindi sempre ringraziare per ciò che si ha, sia in quello che occorre cercare di migliorare e migliorarsi, senza cullarsi troppo sugli allori, a cui si aggiunge quello più sfumato, suggerito, come si vedrà, dal corrispondente verso di Luca.
Si arriva così agli ultimi tre versi della preghiera, quelli che lungo i secoli sono stati più oggetto di discussioni e cambiamenti, anche per gli spostamenti di significato che le parole hanno subito nel passaggio dal latino alle varie lingue volgari come l’italiano.
E se non sembrano esserci problemi per il verso «rimetti a noi i nostri debiti», in cui la parola debiti sembra pacifico che sia equivalente al termine “peccati”, anche tenendo conto del verso di Luca, invece non sembra essere così per la locuzione con cui inizia il verso successivo, «come noi li rimettiamo ai nostri debitori», in cui pare che le parole più corrette siano, al contrario, “come anche noi”.
In effetti, se il parallelismo tra il perdono che il Padre concede a noi e quello che noi dovremmo concedere ai nostri fratelli risulta essere molto importante per Gesù, tanto che, sia in questo Vangelo, sia nell’altro di Luca, sia, indirettamente nel solo versetto di Marco (cap. 11, 26) che riguarda la preghiera, vi è una spiegazione apposita per questo passaggio, il testo ufficiale, invece, ha stabilito, con l’appoggio del corrispondente verso di Luca, che la versione più corretta sia quella che recita: «come anche noi li rimettiamo…», in modo che il parallelismo non sia troppo stringente per noi, che, purtroppo, non riusciamo mai a perdonare gli altri nella stessa misura in cui il Padre perdona noi, considerato anche ciò che afferma lo stesso Papa Francesco, citando un proverbio spagnolo: «Dio perdona sempre, noi qualche volta, la Natura mai!» Speriamo tutti davvero che sia così!
Però è sul verso successivo «e non ci indurre in tentazione» che si è concentrato il dibattito più grande, tanto da suggerire al Papa di effettuare una modifica al testo, perché nel corso dei secoli il significato del verbo originale latino “inducere” è lentamente slittato, dall’originale “condurre dentro, penetrare” a quello odierno di “istigare, spingere verso “, che non è certamente un verbo appropriato per il Creatore, che, per sua natura, agisce sempre per amore. Solo che il verbo proposto per la sostituzione, “abbandonare (alla)” risulta essere forse peggio del significato odierno di indurre, perché così significherebbe che Dio ci abbandona alla tentazione, come si abbandonerebbe un bambino o un animale, incapace di difendersi da solo. Il verbo, anzi la coppia di verbi più adatta, potrebbe essere piuttosto “non far(ci) persistere (in tentazione)”, “non far(ci) durare (in tentazione)”, “non far durare (la tentazione)”, perché così si sposta l’attenzione sulla durata della tentazione stessa e sulla nostra incapacità di resistervi, senza l’aiuto divino.
Si arriva così all’ultimo verso della preghiera, «ma liberaci dal male», in cui “dal male” corrisponde al latino “a malo”; se non che malo si può tradurre sia con il termine astratto e, neutro in latino, “male“, sia con il maschile, concreto, “Maligno”, ossia il diavolo o Satana che dir si voglia. La differenza non è di poco conto e corrisponde a due visioni dell’uomo e del male, con cui si ha a che fare.
Chi crede che il male sia operato da un’entità personale e sovrumana, che agisce per perseguitare l’uomo stesso, essendo questi fatto ad immagine e somiglianza di Dio, non potendo accanirsi contro di Lui, e a cui l’uomo stesso non può opporsi senza l’aiuto di Dio, che lo ha già sconfitto all’inizio dei tempi, o meglio, ancora prima, per mezzo di San Michele, essendo il diavolo solo un angelo ribelle di nome Lucifero, allora lo traduce con il maschile Maligno.
Chi invece pensa che il male sia all’interno dell’essere umano e ne costituisca un limite strutturale, almeno fino ad un certo punto migliorabile con la cultura e l’educazione, ma non in tutto e per tutto (per quello occorre il Figlio di Dio e il Suo ruolo di “Restauratore”, anzi, meglio ancora, come si direbbe oggi, di “Ottimizzatore” per l’Uomo, nella storia della salvezza), lo traduce con l’astratto “male “. Non ci si pronuncia ora su questa questione piuttosto importante, perché significherebbe anche riconsiderare il concetto stesso di “peccato originale” e non è certo il caso in questa sede.
Il brano si chiude, infine, con la spiegazione di Gesù al parallelismo tra perdono di Dio e perdono da noi accordato ai fratelli: « 4Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; 15ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe», che viene indirettamente confermata dal solo versetto di Marco (11,26) sul «Padre Nostro…»: «Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati». Come si vede, soprattutto dalla spiegazione di Gesù, il parallelismo sembra essere piuttosto stringente; speriamo solo che la Misericordia divina, come si è già detto, non applichi, nei nostri confronti, proprio la stessa misura con cui noi perdoniamo ai nostri fratelli.
Invece, per quanto riguarda Luca, il passo interessato si trova in 11, versetti 1-4:
1Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: "Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli". 2Ed egli disse loro: "Quando pregate, dite:
Padre, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno;
3dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,
4e perdonaci i nostri peccati,
perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore,
e non ci indurre in tentazione".
Come si è già notato all’inizio, il brano comincia con Gesù e i suoi discepoli che hanno tra loro un rapporto quasi come quello tra un filosofo greco e i suoi allievi, con il Salvatore che richiama il rapporto tra Platone e Socrate, ma il parallelismo termina qui, perché vuole solo indicare la volontà dei discepoli di ricevere insegnamenti da Gesù, come quelli di Giovanni il Battista.
Passando quindi al testo della preghiera vera e propria, si nota come, rispetto a quello di Matteo, sembra essere un riassunto del precedente. Ci si limiterà pertanto ad evidenziare qui le differenze rispetto all’altra versione e ciò che comporta rispetto al significato globale dell’intero scritto
Si nota perciò che:
- nel primo verso non c’è alcun riferimento alla collocazione del Padre, mentre si sottolinea l’esigenza di santificare, cioè di rendere più importante di tutto, il Suo nome;
- nel secondo verso si evidenzia la necessità di realizzare sulla terra il regno di Dio, ma non c’è alcuna indicazione su come farlo praticamente, come se il Regno si realizzasse solo nell’oltretomba:
- nel terzo verso si parla del sostentamento materiale che Dio deve darci ogni giorno, come fece con le quaglie e la manna nei confronti del popolo ebraico nel deserto, in modo quasi uguale all’altra versione, ma pare ponendo maggiormente l’accento sulla continuità della fornitura, senza la quale ogni programmazione umana del futuro è impossibile, anche perché l’avverbio “oggi” risulterebbe altrimenti una inutile aggiunta rispetto all’aggettivo quotidiano, che già di per sé significa “necessarie per oggi” e viceversa: la versione più corretta sarebbe dunque “Dacci ancora oggi il nostro pane quotidiano”;
- nel terzultimo e nel penultimo verso vengono confermati sia l’equazione tra “debiti” e “peccati”, nell’essere tra loro sinonimi, sia il parallelismo tra il perdono di Dio e quello che dovremmo accordare ad ognuno che presenta colpe nei nostri confronti, anche se a prima vista questo sembra essere più mite che nell’altro passo evangelico ed è a ciò che forse si sono ispirati nel redigere il testo ufficiale della preghiera, che infatti pare essere una collazione, un confronto e poi un collage, tra i due testi tramandatici;
- nell’ultimo verso, infine, si conferma la richiesta di non farci restare troppo in tentazione, attraverso il significato originario del verbo “indurre”, di cui si è già parlato nell’analisi del passo precedente, ma rispetto a quest’ultimo non è più presente l’invito a liberarci dal male o dal Maligno che dir si voglia, forse perché il male è talmente connaturato nell’essere umano, che tale liberazione avverrà totalmente solo nell’altro mondo e grazie al Figlio di Dio, che avrà interamente messo da parte il “peccato originale”.
Ma questa del “peccato originale” è tutta un’altra storia e tutta da scrivere.
E poi tanto, alla fin fine, nonostante tutti i problemi linguistici evidenziati (c’è anche quello per cui Gesù parla al suo pubblico in aramaico, un ebraico antico, divenuto con il tempo una specie di dialetto, mentre i Vangeli ci sono stati trasmessi in greco...), ogni volta che diciamo il «Padre nostro...,» penserà Gesù stesso a presentarlo al Padre, come se fosse la prima volta.
Perpetua
POSTILLA (crf. Post su Fb della cara Antonella del 7ottobre2024)
Dimenticavo di far notare (ma la cosa è talmente ovvia che è la prima evidenziata dai commentatori) come la religione cristiana sia, forse, la sola a chiamare il Dio unico, il Dio supremo, il Dio Creatore, il Dio terribile, Signore degli eserciti (così è definito nell’Antico testamento), Quello che, secondo l’Islam, possiede novantanove nomi, con l’appellativo di “Padre”, anzi, per meglio dire, di papà, visto che così sarebbe più esatto tradurre l’ebraico “Abbà”, che, con la sua ripetizione rovesciata della “B “e della “A”, ben riproduce il balbettìo dei bambini più piccoli.
Tutto ciò per dire che in fondo ci rivolgiamo a Dio Padre come un bambino piccolo al suo papà, con la fiducia, anzi la certezza di essere in qualche modo esauditi nelle nostre richieste.
Perpetua